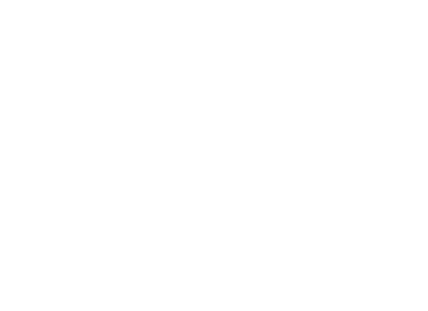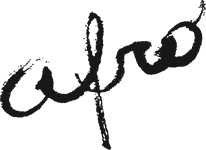Per l’arte italiana Afro rappresenta il punto più alto del rinnovamento nell’alveo della grande tradizione pittorica: nessuno come lui ha saputo cogliere all’interno dei codici espressivi della modernità quegli elementi che collegavano il nuovo alla memoria, e alla memoria classica della pittura italiana.
Questa sublime capacità, tradotta in opere compiute a partire dal 1948 circa, e condotta avanti sino alla fine dei suoi giorni, nel 1976, è stata senz’altro il motivo del suo successo internazionale, e contemporaneamente la ragione del suo parziale oblio negli anni più recenti, nonché la causa di una presa di distanza mista a riguardosa stima con cui l’artista è stato considerato proprio in Italia, sia nel suo momento di maggior visibilità – gli anni cinquanta e sessanta –, sia nel successivo periodo di doveroso consolidamento storico del suo lavoro.
Così, Afro potrebbe essere visto come il pittore della classicità italiana, ben cosciente dei mutamenti storici, concettuali, stilistici e formali che si andavano formulando nel crogiolo degli anni cinquanta, e altrettanto convinto della duratura validità di un’attività artistica basata sugli elementi tradizionali della pittura, quali luce, composizione, segno, colore.
Di questa riuscita intenzione il mondo dell’arte si è accorto rapidamente, e soprattutto unanimemente: non ci sono mai stati dubbi sulle sue qualità, semmai ci sono state diverse interpretazioni del valore di queste qualità, soprattutto se riferite alla situazione generale dell’arte, e non alla bontà indiscussa dell’opera.
In altre parole, se Afro ha avuto un grande successo di critica e di mercato in America (dal 1950 al 1976 ha allestito ben quattordici mostre personali negli Stati Uniti, e ha partecipato a ben quarantatrè collettive, molte delle quali itineranti), se è stato molto presente in Germania, partecipando alle prime tre edizioni di “Documenta” e realizzando molte personali (una delle quali, forse la più importante, alla Mathildenhöhe di Darmstadt, nel 1969), lo si deve proprio alla peculiarità di essere considerato, a ragione, come il più tipico esponente di un’arte italiana che aveva saputo rinnovarsi, ma che manteneva intatte quelle caratteristiche e quelle qualità che il mondo aveva sempre riconosciuto alla pittura italiana, sin dai tempi del Rinascimento.
Allo stesso modo, a mio avviso, questa straordinaria attitudine di Afro veniva in Italia valutata quasi come un retaggio eccessivamente pesante per un’arte che intendeva “mettersi al passo” a tutti i costi con le contemporanee esperienze europee e americane, anche a costo di rinunciare a ciò che ne aveva costituito la grandezza e l’originalità nel passato, e in più questa ispirazione tradizionale e nuova insieme veniva dalla critica nazionale attribuita anche a molti altri artisti italiani, talora ritenuti persino più “meritevoli” di successo di Afro, pittore silenzioso, solitario e apparentemente poco combattivo sul piano dell’impegno per il rinnovamento dell’arte (forse non è un caso che il più alto riconoscimento ricevuto in patria sia stato il Premio per il migliore artista italiano, alla Biennale di Venezia del 1956: premio importante, ma comunque “minore” rispetto agli altri delle stessa manifestazione, cui il pittore aveva partecipato a vario titolo per ben cinque volte, e due con una sala personale).
Questo atteggiamento ambivalente nei confronti della sua pittura – consapevolezza dell’importanza dell’artista, ma contemporaneo distacco da un’esperienza considerata troppo compiuta in se stessa –, già latamente presente nei due decenni di massima attività, si ritrova anche negli anni successivi alla sua scomparsa, quando si analizzi la sua fortuna critica postuma.
Se, come è vero, Afro è il pittore della compiutezza formale, della rinnovata classicità espressiva, della perfezione compositiva (caratteristiche che si potrebbero attribuire anche agli altri due grandi artisti italiani coevi, Alberto Burri e Lucio Fontana, ma che in questi vengono affiancate da elementi “d’avanguardia”, che in Afro non ci sono…), non è incomprensibile il periodo di offuscamento critico che ha subito a partire dagli anni settanta del XX secolo: un’epoca di messa in discussione di ogni “unità” concettuale, tutta tesa all’atomizzazione delle esperienze linguistiche, dominata dal concetto di frammentazione e di “distribuzione orizzontale”, di “rete” senza gerarchie preordinate, difficilmente poteva apprezzare appieno un’esperienza come quella di Afro, improntata alla sintesi, all’armonia, alla più alta idea di “forma”, a tutto ciò, che, in una parola, corrisponde al concetto storico-filosofico di “classico”.
Tuttavia oggi, passato il momento virulento dell’affermazione totale e totalitaria delle nuove idee postmoderne, la figura di Afro comincia a ritrovare motivi di nuovo interesse dal punto di vista storico – come valutazione della persistenza dei valori della pittura anche in un periodo e in un ambiente fortemente permeati dall’ansia del nuovo –, e dal punto di vista critico – è l’esponente in fondo più radicale dell’azione tradizionale del dipingere, come potrebbe essere, in Francia, Nicolas de Stäel, o in America Arshile Gorky, artista idealmente molto vicino all’italiano, come vedremo –, mentre sul versante del mercato si deve registrare una costanza abbastanza insensibile al gradimento della critica e del trend della moda: i valori di Afro sono tuttora altissimi per un artista italiano, e anche se negli anni cinquanta una sua opera costava negli Stati Uniti assai di più di un lavoro di Willem De Kooning (andamento oggi ampiamente ribaltato, come si sa), ancora adesso le sue valutazioni sono tra le più alte per gli artisti italiani del secondo dopoguerra, e ben difese e sostenute sul piano internazionale.
Ma come si raggiunge la classicità? Nella vita di Afro è stato un percorso o un’illuminazione? Un processo o una scoperta?
Ovviamente non esiste una risposta netta, ma di sicuro alcuni indizi disseminati lungo tutto l’arco dell’attività dell’artista e il ripetuto riferimento della critica a elementi costanti del suo lavoro farebbero supporre che per Afro il primo movente per la sua opera di pittore sia stata da subito la ricerca di un’unità formale che fosse l’espressione concreta (persino nel senso critico di “Konkrete Kunst”, così dibattuto in Italia alla fine degli anni quaranta) di un’unità ideale, se non persino etica.
Anche escludendo il periodo di apprendistato di Afro, a Roma, negli anni immediatamente precedenti la guerra, che comunque corrisponde alle stesse caratteristiche – la cosiddetta “Scuola Romana”, il rapporto con Corrado Cagli, figura d’artista forse non di primissimo piano, ma fondamentale per molti grazie agli stimoli critici di cui era prodigo, i soggetti trasognati, a metà tra il Severini classicheggiante e la magia delle atmosfere metafisiche –, il periodo della sua piena maturità appare come il lento fluire di un fiume senza anse e senza troppi rami collaterali, come un percorso sicuro privo di ostacoli e tutt’al più con qualche piccola variante.
Parlando di lui, si è molto discusso – soprattutto negli anni cinquanta e sessanta – proprio su questa impressione: se Afro, nonostante i pochi riconoscibili cambiamenti di stile pittorico (almeno due importanti: attorno al 1948 e verso il 1956-57), si sia mantenuto perfettamente coerente con la propria idea di pittura, e la risposta è quasi unanimemente positiva, a maggior ragione oggi quando, interposta una discreta distanza storica e critica tra il nostro sguardo e quei momenti creativi, si coglie il suo discorso come unitario, inserito in un periodo che stava dando inizio a quella frammentazione di poetiche e di tendenze che stiamo vivendo tuttora.
Di fatto, il guardare all’opera di Afro come a un tutto unico, non fa che avvalorare l’idea che egli abbia avuto ben chiaro dall’inizio l’obiettivo della sua ricerca, e sia andato diritto al bersaglio con la consapevolezza di volere perseguire solo quell’unico, indispensabile risultato. Così, la storia critica del suo lavoro è una storia di “varianti” innestate su di un “continuum” ideale, così come potrebbe essere la storia critica di Matisse o, più vicina anche allo storia dell’arte italiana, quella di Giorgio Morandi.
Di fatto, in questi anni – 1948-52 – la ricerca di Afro è centrata sulla soluzione di problemi linguistici, intrinseci alla pittura, come quello fondamentale del rapporto tra figura e sfondo che poi, in senso lato, è il problema dello spazio. In questo senso ho appena parlato di analiticità: il soggetto dei quadri di Afro non è la figura o l’azione da questa intrapresa, ma la relazione tra la figura e lo spazio all’interno di un universo finito, che è quello della tela. In questo modo si ritorna a quel concetto di classicità, che non esclude una sorta di razionalità cartesiana, e neppure una specie di consapevole curiosità verso altri modi di dipingere, altre idee sulla pittura.
Ad esempio, dopo i viaggi americani – il primo data al 1950, in occasione della prima mostra da Catherine Viviano – cresce in Afro l’interesse e la stima per Arshile Gorky, cui lo accomuna una qualche vicinanza formale, derivata però da motivazioni assolutamente diverse, che pure Afro apprezza e comprende, sino a trarne l’unica lezione che egli stesso, con la sua indole, poteva ricavare dall’artista americano: non l’angoscia esistenziale dell’ armeno, ma la libertà di un segno non più così strutturato, come era invece quello della sua prima maturità (lo stesso rapporto di stima, stavolta reale e non solo ideale, Afro lo stringerà con alcuni esponenti dell’espressionismo astratto statunitense: quando Willem De Kooning andrà per qualche mese a Roma, nel 1960, sarà ospite di Afro, col quale lavorerà a una serie di grafiche, una delle quali espressamente dedicata all’italiano. Concettualmente nulla avvicina i due, ma umanamente si tratta dell’incontro tra artisti che hanno trovato una soluzione al problema di una “tradizione del nuovo”, e che per questo si apprezzano.).
È questo concentrarsi in maniera assoluta sui problemi intrinseci al linguaggio dell’arte che crea gli equivoci critici per cui Afro sarebbe il rappresentante di una pittura in fondo manierista, leggera, decorativa, astratta dalla vita: tutte accuse superficiali, ma sintomatiche di un periodo – gli anni cinquanta, soprattutto – in cui l’aspetto ideologico del fare arte stava alla base di ogni giudizio di merito, e da cui l’artista è sempre rifuggito, cercando, nei pochissimi scritti sul proprio lavoro, di spiegare le ragioni di una pittura a tutto tondo, senza necessità di “stampelle” ideologiche. “Sebbene a molti – scrive in una lettera del febbraio 1953 – i miei quadri sembrino delle divagazioni arbitrarie, io tendo sempre a dare alle mie immagini pittoriche la maggior efficacia espressiva, la più evidente.
Queste immagini sono ancora un corrispondente poetico della realtà, di cui la memoria conserva la parte più essenziale, rifiutando tutto [ciò] che sia pratica ed esperienza. Una realtà decantata, direi liberata da legami razionali per cui delle cose vorrei arrivare alla figurazione più diretta e concisa – direi all’‘idea’ delle cose. Evidentemente una forma pittorica in me non nasce mai solamente come forma, né un colore si giustifica solo nel suo rapporto di valore e di spazio, ma ha bisogno di caricarsi di un significato espressivo, direi di sentimento, per cui una forma dovrà avere un determinato carattere e il colore quel particolare timbro e il segno quella immediata trepidazione che hai nell’urgenza di dire una cosa che ti viene da dentro quando non vai a cercare il modo più bello per esprimerti, ma sei unicamente preoccupato di esprimere il concetto. Anzi, proprio perché non hai preoccupazioni formali la forma sarà la più adatta e la più originale. La pittura così intesa nel suo rapporto con la vita da cui continuamente si alimenta e si rinnova, ti investe in modo totale, per cui tu ci sei dentro con tutte le tue reazioni, lati del carattere, ossessioni, uno spiraglio aperto sulla tua anima.”
Da questa lettera, oltre all’intenzione di rispondere alla sciocca accusa di formalismo (in quegli anni essere accusati di formalismo era come essere accusati di disimpegno sociale), si evidenziano alcuni elementi costanti della sua poetica: un’idea trascendente della realtà, neoplatonica forse, in cui non è neppure la ragione a condurre il gioco, ma la memoria, cioè qualcosa di più sfumato e di più complesso, in cui entrano anche i sentimenti. Si potrebbe parlare probabilmente di “stato d’animo”, rifacendosi anche alla recentissima tradizione della pittura futurista, e in particolare di Umberto Boccioni, basata appunto sugli “stati d’animo”: una pittura non totalmente psicologista, non solo razionale e non solo soggettiva, ma attenta al rapporto tra soggetto e oggetto, colto nella particolarissima situazione di sensibilità osmotica tra sé e realtà.
Conscio della propria sicurezza, indifferente alle critiche contingenti, in fondo solidamente “borghese” – come può esserlo uno Jean-Baptiste-Siméon Chardin o, ancora, un Giorgio Morandi –, Afro non corrisponde mai integralmente al proprio tempo, e forse neppure a un tempo storico: è “inattuale”, e ne era contento.