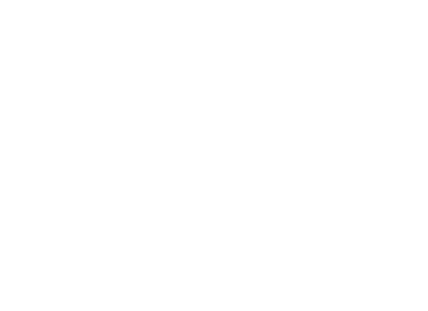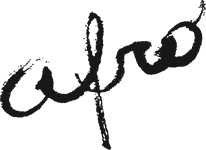La pittura ultima di Afro registra dagli ultimi anni sessanta notevoli cambiamenti di linguaggio, culminati nel 1975, alla vigilia della morte dell’artista, in una vera svolta, come la critica, tutta e da sempre ha sottolineato. Nel 1968-69 Afro rallenta l’energia del gesto, organizza la materia in campiture librate in una sospensione nostalgica, come carica di valenze evocative, immersa in toni uniformi, da cui affiorano leggeri sommovimenti. Verrebbe da dire di una qual “metafisica” atemporalità, ormai lontana dalla flagranza dell’accesa segnicità messa in atto dal pittore all’inizio degli anni sessanta, quasi in uno scontro col supporto, determinando nuclei plurimi di organizzazione figurale, con effetti anche di apertura centrifuga. Con una tensione che già si allenta alla metà del decennio. Dal 1966, infatti, le spinte centripete vanno riaffermando il loro peso, portando al ritrovamento di sempre più riconoscibili e dominanti nuclei di aggregazione. In opere nelle quali si avverte un’inclinazione di meditativa introspezione, anche nei termini della riproposizione dei valori della cultura originaria, pure in senso antropologico, dopo la stretta tangenza con i fermenti di un mondo tanto differente come quello statunitense, e in particolare newyorkese.
Nel 1970 il recupero di un centro dell’immagine si accentua, anche per le stesure cromatiche che isolano, quasi, il nucleo su fondi in genere quasi uniformi. Così, tra i dipinti di quell’anno (ma già in quello precedente erano su tale registro, ad esempio, Oltremare, Nero quarto, e più ancora Rosso di sera), in Etnea o in Arancio ceruleo. Non di rado, poi, la centralità della composizione si sposa – o è sostituita – dalla dislocazione, invece, lungo un asse orizzontale (Nero, Vulcano 1 e 2, Grande grigio4) o più eccezionalmente, a questa data, verticale (Senza titolo). Si fa inoltre più evidente la calibratura degli episodi figurali, ormai quasi geometrici, che si dispongono come a incastro, con un irrigidimento dei margini e dei nessi sintattici. Afro definisce zone uniformi, dapprima ancora vibranti per un colore-luce tenuto su toni bassi, profondi, poi sempre più nette, con stesure più piatte. Come già nel 1970 nei succitati Senza titolo e Vulcano 1, e nel 1972 in A lume di candela, o in La quinta, misteriosa quasi kleeiana, nel suo sospeso suggerire qualcosa di indicibile, di emozionalmente teso, ma di un’emozione che intimamente coinvolge la mente e il pensare. E subito dopo, nel 1973, in Doppio peltro, Il domino, Il cancello, non diversamente che, l’anno successivo, in Bandiera ombra, in Tormarancio o in Piccola terra.
Ancora, in quegli anni, Afro si raccoglie con sommessa musicalità in un suo mondo segreto, dai tempi lunghi, dove va a grado a grado perdendosi quella concentrazione centrica medesima – compositiva, ma significante – cui era appena approdato. Ecco capolavori di intensità quali i ricordati Grande grigio e La quinta, oppure Doppio peltro o Fuori porta, sempre, peraltro, entro quel precisarsi di forme e rapporti di cui s’è detto. Con qualità quasi grafiche, che hanno infatti indotto a pensare a una connessione con la particolare applicazione di Afro, in quegli anni, appunto alla grafica, come subito si dirà. Dopo aver richiamato la testimonianza illuminante, e precoce, nell’anno stesso della morte del maestro, di Cesare Brandi, dagli anni trenta suo studioso e sodale.
“È nel ’69 che si incominciano ad avvertire i prodromi di una svolta che diviene considerevole nell’attività di Afro”, scrive Brandi iniziando a esaminare, a ridosso dei fatti, quest’ultima stagione del pittore. E continua: “Intanto tendono a scomparire o a ridursi al minimo anche gli avanzi di quei grafismi che avevano avuto un ruolo preponderante dal ’48 in poi: le pennellate sfrangiate si rassettano, si dispongono ad assumere una configurazione più geometrica, di toppe di colore, quasi tasche applicate e sovrapposte”. Poi, “nel ’70 […] il dipinto si disporrà come un ‘campo’, dove elementi non significanti, ma rigidi e ritagliati, come può essere ritagliata una maschera, si dispongono in una balance intuitiva, di cui non si può dare una giustificazione razionale, e che tiene in modo quasi misterioso. […] Ciascuno di quei ‘ritagli’ colorati individua un piano diverso, anche se rigorosamente parallelo alla superficie del quadro: e il fondo, questo fondo impastato di cenere, sedimento d’ombra, ma di un’ombra che è un’ombra di luce, è come se stesse a tutela e garanzia di una spazialità che non si riduce alla superficie ma neppure ‘inventa’ una profondità. Necessariamente bisogna esprimersi per antitesi, perché di questi quadri non si può parlare che dicendo quel che non sono, essendo, quello che sono, solo in funzione di questa privatività strutturante”.
“Si può anche supporre come Afro sia giunto a questo che, se non è un capovolgimento, è la sterzata più robusta che egli abbia dato alla sua pittura”, conclude Brandi, che avanza l’ipotesi, poi largamente fortunata nella “decifrazione” di questo particolarissimo “ultimo Afro”, di una connessione con la pratica della grafica. Infatti, ricorda il critico, proprio nel ’70 Afro “intensifica l’attività di incisore avvalendosi in primo luogo della tecnica dell’acquatinta, che gli permette di evitare o quanto meno di ridurre al minimo un segno di contorno” e “ha potuto legarsi alla possibilità di arricchire l’incisione di colori”, con un “risultato, come si poté vedere in una mostra del ’74 di tutta l’ultima produzione ’70-74 che fu sorprendente: queste incisioni, in un certo senso, erano più pittura delle pitture”.
La mostra cui si riferisce Brandi è quella proposta nel dicembre 1974 dalla Galleria 2 RC, stampatrice delle incisioni esposte. La presenta in catalogo Nello Ponente, che scrive: “Le tecniche dell’incisione non possono venir considerate come un momento occasionale e fortuito dell’esperienza dell’artista, bensì riprova, testimonianza e, soprattutto, momento dialettico di una ricerca, di una essenzializzazione, di una sperimentazione di tempi e valori, di spazi e campiture, di automatismi e intenzionalità”. “E tutto”, rileva Ponente, “serve ad arricchire, a modificare, ad evolvere in definitiva, i motivi che Afro elabora nella sua pittura e che dunque comportano nuovi problemi e nuove soluzioni di struttura”.
Ciò è evidente già in quei fogli che accompagnano – in tale attiva interrelazione, appunto, con la pittura – i quadri degli anni tra il 1970 e l’iniziale 1974, cui si riferisce nella sua analisi Brandi. Ma è ancora più netto in altre incisioni di quel medesimo 1974, nelle quali non solo gli incastri di forme si fanno maggiormente definiti, con una qual limpida, più fredda ritmica compositiva, ma i colori stessi divengono più puri, talora anzi timbrici, senza vibrazioni, differenze di toni o velature, come, tra le opere esposte in quell’occasione, in Santarossa. Il passaggio a tali “nuove soluzioni di struttura” e di colore, dovute anche ai “nuovi problemi” provocati dal lavoro nella grafica, per riprendere le parole di Ponente, è graduale, fino a sfociare l’anno dopo – l’ultimo, purtroppo, di attività di Afro – in composizioni che paiono tarsie dai colori luminosi e squillanti e costituiscono una svolta effettiva nel percorso creativo del maestro.
Sono immagini veramente sorprendenti, nelle quali pare di avvertire gli echi di una tradizione tutta italiana, con radici secolari, ripropostasi tra i finali anni quaranta e i primi cinquanta in certo nostro concretismo, per esempio di Prampolini, ma pure in certe cose di Cagli e di Burri. E allora l’allargarsi di siffatte inedite modalità alla pittura, negli stessi mesi ultimi del 1974 e nel 1975 – in mostra documentato da Bandiera di contrada, 1974, Arena ’74, 1974, Controsenso, 1975, Tivesia 1975, che concludono la retrospettiva con notazioni d’una serenità non priva di accenti gioiosi, e purtuttavia come abbandonata ad una vena di nostalgica melanconia – non è riduttivamente da ricondurre al dialogo, pur certo, come s’è detto, attivo, tra media differenti. Come il medesimo rapporto che questi fogli e queste tele postulano con Burri. Sì da dipanare nei suoi tempi e nell’individuazione del reciproco dare e avere – nell’evidente precedenza dei lavori di Afro su quelli affini del pittore umbro tra la fine degli anni settanta o i primi ottanta e negli altrettanto indubitabili precorrimenti, diretti o meno, nei confronti di Afro del Burri della fine degli anni quaranta o di quello, nell’opera grafica, tra anni sessanta e settanta – e quindi della singolarità e autonomia dei risultati di ciascuno dei due autori. Ma anche da valutare considerando il senso, in quella congiuntura, di tale riaffacciarsi di valori di stretta formalizzazione, di cui entrambi appunto partecipano. Ed è un nodo tuttora da sciogliere, considerando anche il ruolo avuto da un personaggio come Brandi, di Afro e di Burri compagno di strada.
Se la pratica nel campo della grafica non può spiegare il perché e il come della svolta dell’ultimo Afro, ma solo forse a contribuire a illuminare una condizione propizia al suo definirsi e svolgersi, similmente non conclusive né esclusive sono le valutazioni che possono derivare dalle conseguenze della malattia che in quegli anni afflisse Afro. Sulle quali s’è soffermato un volume recente, edito nel 1994, frutto di ricerche di area e impostazione neurobiologica coordinate scientificamente da Anna Mazzucchi. Titolo e sottotitolo – Cervello e pittura, effetti delle lesioni cerebrali sul linguaggio pittorico – evidenziano con chiarezza la prospettiva di indagine, da tenere ben presente per un approccio corretto, fuori di adesioni acritiche come di negazioni totali preconcette, le une e le altre inidonee a un accostamento, e quindi a un giudizio, motivati. Come non va persa di vista la funzionalità dichiarata del libro, quella di acquisire maggiori e migliori conoscenze ai fini della neuroriabilitazione.
Dei pregi e dei limiti di una suddetta indagine scrive onestamente Mario Parma. Che introducendo il volume muove da un interrogativo di base: “È possibile esplorare e conoscere come e dove nelle strutture e nei processi cerebrali si genera la creatività artistica?”. Per rispondere che, “sotto l’aspetto neurobiologico, la creatività artistica, come ogni altra attività creativa, appare, nell’universo della mente, una terra ancora largamente incognita e impervia agli attuali metodi di indagine ed anche a modelli di speculazione teorica: metodi e modelli che pur hanno consentito grandi progressi nella conoscenza di attività cerebrali meno altamente evolute e più dissociabili funzionalmente”; e che “tuttavia, se si accettano i molti attuali limiti di ordine metodologico e conoscitivo, una prima rivelazione di semplici fatti è pur sempre possibile”.
Su tale piano, i ricercatori hanno esaminato l’opera pittorica di alcuni artisti, di differente estrazione, epoca, linguaggio e “stile” che hanno subito delle lesioni cerebrali, confrontando i prodotti eseguiti prima e dopo l’avvento delle lesioni stesse. Tra i “campioni”, anche Afro, che subì un primo ictus nel gennaio 1971, un secondo nell’agosto del medesimo anno, e un terzo nell’aprile 1975, con gravi conseguenze cerebrali e fisiche. Eventi in relazione ai quali sono state analizzate le opere, conseguendo i risultati di cui dà conto un valente storico dell’arte, Dario Trento, che prospetta i nessi tra gli effetti rilevati sperimentalmente in pazienti affetti, come Afro, da lesione emisferica sinistra (essendo diversi quelli dovuti a lesione emisferica destra) e quelli riscontrabili nella ideazione e fattura delle opere dell’artista. Con corrispondenze e coincidenze che il carattere di questo scritto impedisce, prima di tutto per ragioni di spazio, di esporre anche solo sommariamente, ma che non possono non colpire.
Se non manca qualche pericolosa uscita dai confini sperimentali (alcune lastre incise tra il 1968 ed il 1969, prima, quindi, delle lesioni cerebrali “sembrano documentare ad evidenza una notevole perdita di controllo dei mezzi stilistici”, annota Giovanna Pesci), in genere le considerazioni meritano attenzione. Quel che tuttavia non consente l’applicazione meccanica dei confronti attuati è l’incertezza sull’attribuzione, qualitativa e quantitativa, all’attività artistica di quanto vale per altri ambiti, pur in presenza di identiche menomazioni fisiche.
Certo, tuttavia, al di là anche di problematici e discutibili parametri teorico-estetici, c’è, da vedere e toccare, l’eccellenza degli esiti ottenuti da Afro già colpito dai suddetti malanni. Anche se, per quanto sopra s’è detto, si dovesse riconoscere una qualche influenza su di essi della malattia, ciò si risolverebbe in un ulteriore fattore positivo nella valutazione qualitativa delle pitture. Da considerare nei termini di una condizione dell’operare, indubbiamente, in questo caso, particolarmente coinvolgente. Ma non necessariamente solo vincolante. Anzi, parrebbe, tale da stimolare un dinamismo e un arricchimento inventivo, nell’ideazione e nella resa dell’immagine, di cui gli scienziati dovrebbero tener conto, per ribaltare, in un certo senso, la direzione, e, in parte almeno, i presupposti del loro indagare.