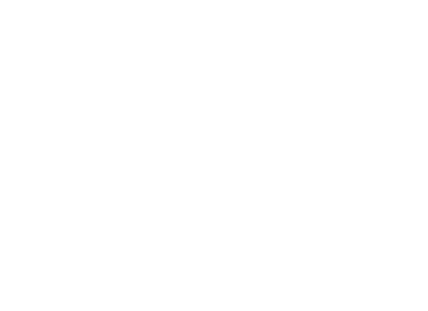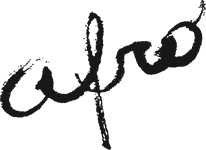Sarebbe probabilmente pretestuoso immaginare ancor oggi un caso Afro dovuto ad una incomprensione o ad una disattenzione critica che in realtà non v’è mai stata; men che meno oggi, in tempi di riesami e di nuove attenzioni per quel decennio e per quella generazione che, alla fine del Fascismo, ricollocò l’arte italiana nello scenario internazionale. Eppure va egualmente segnalato che la fortuna critica che praticamente non ha mai smesso di accompagnare il maestro friulano, ha continuato a rivelarsi monca, abbastanza miope e riduttiva.
Anche recentemente, leggendo il saggio di Marco Meneguzzo, introduttivo al catalogo della rassegna dedicata ad Afro dalla città di Darmstadt, ho riconosciuto le tracce di una visione della sua arte assolutamente corretta, ma anche un po’limitante e settoriale. Meneguzzo apre il suo ragionamento ricordando, molto propriamente, che: ”Afro rappresenta il punto più alto del rinnovamento nell’alveo della grande tradizione pittorica: nessuno come lui ha saputo cogliere all’interno dei codici espressivi della Modernità quegli elementi che collegavano il nuovo alla memoria, e alla memoria classica della pittura italiana. Questa sublime capacità è stata senz’altro il motivo del suo successo internazionale, …nonché la causa di una presa di distanza mista a riguardosa stima con cui l’artista è stato considerato proprio in Italia, .. Così Afro potrebbe essere visto come il pittore della classicità italiana, ben cosciente dei mutamenti storici, concettuali, stilistici e formali che si andavano formando nel crogiuolo degli anni Cinquanta, e altrettanto convinto della duratura validità di un’attività artistica basata sugli elementi tradizionali della pittura, quali luce, composizione, segno, colore…Se, come è vero, Afro è il pittore della compiutezza formale, della rinnovata classicità espressiva, della perfezione compositiva…”
Tutto vero, tutto giusto, tutto in perfetta sintonia con quanto sempre affermato da tutti (compreso il sottoscritto), perfino con quanto riportato in testi fondamentali, come quelli di Luciano Caramel per Palazzo Reale a Milano e Palazzo Flangini a Sacile, e di Enrico Crispolti per il libro sui Basaldella, edito da Casamassima, ma probabilmente troppo poco, ancora troppo poco. L’unicità di Afro a me è parsa consistere in quella sua inconfondibile, inarrivabile capacità di sintesi degli opposti, in quella scommessa, in quel tentativo impossibile, da lui risolto naturalmente come “uno sviluppo spontaneo”, di coniugare la tradizione, la classicità con la rivoluzione dell’immagine. A lui che certamente rivoluzionario non era, che non proponeva messaggi o codici ideologizzati, riuscì il miracolo di liberare la pittura dal miraggio della autoaffermazione, da una ricerca tutta rivolta al suo interno, in quella “..operazione autoriflessiva e di rispecchiamento su se stessa che comporta grandi rischi e che tende perciò alla sempre più necessaria ed accentuata giustificazione del linguaggio ridotto alle sue nervature logico-formali.” Ad Afro toccò il miracolo di riportare, anzi di portare nell’arte italiana il sentimento della forma, la sua vitalità, la sua fisica percezione; identificandola nel linguaggio stesso, di cui riassumeva finalmente l’anima.
E questo cominciava ad accadere nei primi anni del dopo guerra, quando anche Afro si rivolgeva alla sintassi cubista, che agli artisti italiani più emancipati appariva come il veicolo, il tramite, oltre che verso la grande scuola picassiana, anche verso una cultura innovativa e di frontiera. Ma fin da quel periodo, egli riuscì ad offrire una personalissima maniera “neocubista”, a presentarsi, nel panorama artistico internazionale, sotto una veste identificabile ed autonoma, con un linguaggio che, se dal punto di vista strettamente grammaticale certamente aveva mutuato molti dei moduli e delle regole cubiste, a sua volta, in questo tessuto ed in questo dispiegarsi di architetture formali, aveva saputo innestare una “vis”, una carica sentimentale assolutamente originale e creativa.
Chi scrive aveva proposto una definizione di “cubismo sentimentale”, che, però, non intendeva sottolineare solamente gli aspetti di partecipazione emotiva, di afflato, di coinvolgimento espressivo, ma anche le nuove, stimolanti e conseguenti innovazioni presentate dal giovane Maestro sul piano stilistico, a conferma di una disposizione al nuovo ed alla invenzione, che ben presto era venuta a confermarsi come una delle caratteristiche peculiari della sua pittura.
Sì Afro fu un inventore, non un rivoluzionario, ma un innovatore, un creatore, un facitore di linguaggi sempre nuovi; non, dunque, quello straordinario conservatore, quel distillatore di sublimi ed estetizzanti alchimie pittoriche, quel formidabile affabulatore per la via del colore, che molta critica, anche celebrata, ha inteso riconoscere in disamine forse un po’superficiali. Certo, fino agli anni della guerra, ricchi comunque di prove di altissima sensibilità( capaci anche di presentare una sua maniera, distinta, se non lontana, dalla “scuola romana”, dalla lezione morandiana, dal classicismo tradizionale : una versione alla Afro della atmosfericità soffice, trasudante nebbie dorate, che permeava, avvolgeva, e sosteneva la intelaiatura dei dipinti di Domenico Veneziano,
Afro si era rifatto a qualcun altro o a qualcos’altro, tanto da far sembrare giustificata la tesi del continuatore, dell’abile manierista. In realtà, ogni accostamento, ogni riferimento, come già avevamo sottolineato nel caso delle analogie con l’arte di Domenico Veneziano(piuttosto che con quella di Piero della Francesca, troppo spesso chiamato in causa), era sempre funzionale, diretto a quel preciso obiettivo formale e non solamente estetico: “I riferimenti, in quegli anni quaranta insistevano su tutto il panorama quattrocentesco e cinquecentesco, magari sottolineando filiazioni(Domenico Veneziano) meno rilevabili nei festosi cicli murali….diventava preminente quella disposizione a far vibrare il dipinto attraverso le corde interne, i registri più intimi.
Era questa una caratteristica già presente, .., in molti dipinti degli anni trenta, .., come una tensione verso l’interno dell’opera, e come una necessità di trasfigurazione in senso un po’onirico del soggetto rappresentato, e che già molto lo allontanava dal dogma di Cagli,… In questo processo di interiorizzazione del quadro, quel vibrato sentimentale che aveva sempre accompagnato Afro, diventava padrone dell’opera anche sul piano linguistico, creando una commistione precisa fra l’afflato emotivo e quel pulsare interno, pacato sommesso, modulato, ma continuo, che andava a liberare i contorni della forma, e soprattutto a smaterializzare e ovattare il colore.”
Così come a proposito degli accostamenti “morandiani”, bene intravedeva Cesare Brandi:”Afro non doveva dipingere come Morandi. Se c’è una pittura che non ammette doppioni, è quella di Morandi. Ma è anche una pittura che, a chi capisce, insegna..una lezione salutare. La lezione della forma ..Basta questo per far capire come s’indirizzasse a Morandi dai margini e non dalla struttura. Ma era ciò che doveva sorbire da Morandi, e cioè una fusione a caldo, una visione interiore, in cui, come nelle immagini della conoscenza, non si può contare le colonne del Partendone, anche se si ricordi benissimo. Questa visione interiore insegnava ad Afro a prendere l’immagine come una cosa in sé, , sceverata da un contesto:quello in cui si inseriva era altro, e, a farlo altro, valeva la luce. Non aveva ancora individuato la luce come uno schermo luminoso-la sua fondamentale scoperta formale-ma neanche era la luce di Morandi…”
E nemmeno era la stessa luce della “scuola romana”, se pur “.. della “ scuola romana”, anche se Cagli non aveva più cittadinanza davvero in questi dipinti, rimanevano ancora molte tracce; soprattutto in certi “fantasmi di paesaggi con rovine”, in cui non si privilegiava, però, il momento dello sfacimento e della decadenza, caro a Scipione, quanto piuttosto quello del sogno; abbastanza lontano, peraltro per motivi opposti, anche dalle amorose e compiacenti descrizioni romane di Mafai.” Comunque, già con l’avvento di dipinti come “Ritratto di Turcato” del 1942, e come alcune nature morte del 1944, egli cominciava a scrollarsi di dosso legami e legacci, riferimenti troppo sottolineati, debiti stilistici che sembravano non solvibili. Ma è con la celebre “Natura morta con tenaglie” del 1947, e con i dipinti dell’anno successivo, come “Occhio di vetro”, “La sfinge “, “Il pianeta della fortuna”, che quegli annunci, quelle anticipazioni si tramutano in una diversa e alternativa interpretazione del linguaggio cubista.
Afro ci propone la sua versione del verbo picassiano, assolutamente innovativa e personale: un unicum rispetto a tutto lo scenario dei vari movimenti in campo in quegli anni. Se il nordico e romantico Vedova, quasi per contrasto, estremizzava, sul piano del rigore e del nitore formale, le rigide architetture che sostenevano la lingua cubista, se il raffinato Santomaso affidava la sua narrazione incantata a bloccate e solide geometrie, se il solare e impetuoso afflato mediterraneo di Guttuso non sapeva comunque rinunciare a quelle gabbie grammaticali, ecco invece che Afro trasformava una scelta ed un passaggio linguistico in una grande occasione di rinnovamento poetico dell’espressione, inventandosi una lingua viva, ricca di ammiccamenti, di allusioni, di interferenze simboliche, perfino di collegamenti geografici con la patria friulana. Iniziava il suo irripetibile-e ancora non misurato-tragitto verso la libertà espressiva: “Ogni riferimento descrittivo viene abbandonato, ogni tentazione narrativa viene superata, in una astrazione strutturata geometricamente, a sottolineare una tensione verso l’alto, verso uno spazio immanente e concluso, ma comunque esterno al motivo rappresentato, o meglio, come dice Lionello Venturi, presentato.
In questo definitivo abbandono dell’aspetto mimetico, gli affascinamenti per la “Metafisica” di rito dechirichiano si traducono in pure allusioni semantiche, o nella ricomposizione di angolarità evidenziate linearmente, in analogia con i triangoli e le squadre degli interni metafisici. Ma anche in sintonia con la destrutturazione e ristrutturazione della forma per definizioni angolari, tipica del linguaggio cubista. Il cui impossessamento non sarà la caratteristica precipua di questo periodo, come invece fu per tanti compagni di strada, che infatti, contrariamente a lui, aderirono in massa al “Fronte Nuovo delle Arti”.
Egli aderì a quel linguaggio.., ma lo utilizzò a proprio uso e consumo, arricchendolo di riferimenti metafisico-surrealisti, di implicazioni simboliste, di echi vagamente nordici, non solo mediterranei. Il linguaggio cubista si coniugava con l’anima friulana, e nasceva così un personalissimo “cubismo sentimentale”, in cui figure centrali, ieratiche, o totemiche, tagliate con secchezza e nettezza di lame, sembravano rimandare a presenze misteriose, potenti e profonde, in una sorta di misticismo della forma.”
E non fu, dunque, già questa una prima stupefacente testimonianza della sua attitudine e intenzione di inventare, di edificare un linguaggio nuovo, che coinvolgesse e sconvolgesse in una sintassi originale, grammatica, semantica e lessico cubista?
Quando poi, dal 1950, prima con una collettiva, ed in seguito con le varie personali dalla Catherine Viviano e presso Colleges e Musei, si tuffò nel mare, nell’oceano burrascoso dell’arte americana, la sua esigenza di libertà, di infinito, di frontiere abbattute, di incontri e di scoperte, si consolidò e fortificò a tal punto, da innestare nella sostanza della pittura una linfa ed un vento rinnovatore di formidabile intensità. Afro non era solo colto, attento e sensibilissimo nel cogliere le pulsazioni e i fremiti del colore, e nell’inquadrare, in una folgorazione implacabile, le architetture di una forma sospesa fra realtà e sogno, fra realtà e memoria; era anche uno degli artisti europei meno provinciali, meno pigri intellettualmente, più golosi del nuovo internazionale. Il suo coinvolgimento nella temperie dell’Espressionismo Astratto, l’entusiasmo dimostrato nel confrontarsi con i grandi rinnovatori della pittura d’oltre oceano, e soprattutto la sua cooptazione in quel gruppo di talenti inarrivabili che tentavano e credevano nella più assoluta libertà d’espressione, rappresentavano la conferma di una scelta di campo precisa, non certamente restauratrice. Non si poteva stare dalla parte di Pollock e di Gorky senza pensare e sentire come loro. Non si poteva infiammarsi di fronte ad “Una fantasia, un colore, un sogno febbrile, che sono di Gorky soltanto..” Non si poteva riconoscere che “Quella pittura mi ha dato coraggio. Intrepido, emozionato, pieno d’amore Arsile Gorky mi ha insegnato a cercare la mia verità senza falsi pudori, senza ambizioni, o remore formalistiche. Da essa ho appreso più che da qualunque altra a cercare soltanto dentro di me:dove le immagini sono radicate alle loro origini oscure, alla loro sincerità inconsapevole”, senza essere profondamente in sintonia con quella poetica.
E d’altronde la ricerca dell’artista friulano era sempre stata indirizzata verso la conquista della forma, intesa come essenza vitale, come anima (e allo stesso tempo architettura )delle cose, non certo verso la conquista di una forma bella. La padronanza del mestiere e la sapienza stilistica erano comunque funzionali a questa ricerca, dovevano fungere da strumenti per poter ritrovare, per poter riconoscere la verità formale (non sempre e non necessariamente in situazione di equilibrio), che per Afro rappresentava l’espressione della verità “tout court”. Il dopo Gorky di Afro è un mondo in cui egli non sopporta più di: “..rappresentare una realtà di fantasia, di sogno o di memoria esistente oltre il quadro, e di cui il quadro era specchio o tramite, ma volevo che quella realtà si identificasse con la pittura e la pittura divenisse la realtà stessa del sentimento, non la sua rappresentazione”.
E non si trattava, dunque, di un’autentica rivoluzione, se pur compiuta da un moderato e con i modi della pittura? Vi fu qualcun altro in Italia, in tutti quegli anni, capace di trasmettere al colore valenze e significati etici e psicologici, di riportare nel colore non solo la rappresentazione della vita, ma la vita stessa? E non solo un aspetto della vita, secondo magari un taglio limitante, attraverso magari la scorciatoia del dramma o della passione(come nel caso dell’energia pregna di drammaticità di Vedova), bensì tutti gli aspetti, tutti i momenti della vita, in una immersione misurata e regolata, ma totale, senza remore e senza condizionamenti, se non quello di una coscienza lucida e ferma.
Il pittore del tono, della misura e della memoria, si manifestava sempre più come il pittore della verità, della realtà assoluta, riportata al suo nitore ed alla sua sostanza primigenia attraverso sì il filtro purificatore della memoria, ma anche e soprattutto attraverso l’irruzione incondizionata della libertà nella coscienza dell’artista: “Per giungere a tali mete Afro deve scavalcare un’intera grammatica, un’intera sintassi:anzi, prima ancora, un’intera concezione dell’arte. Ed è quanto appunto egli fa dal 1951, da quadri come Cronaca nera o come l’altrettanto intenso Giardino d’infanzia, …, oltre le secche epigoniche di certo post-cubismo nostrano, perpetuatosi pure in molto equivoco “astratto –concreto”:un superficiale, e apparente, aggiornamento, non di rado, non un rinnovamento vero dell’immagine. E se pur resta in Afro non secondario anche in questa fase il colloquio con il tema, con le parvenze fenomeniche, ciò avviene per interne esigenze, ..Ben diversamente, quindi, che nelle ambigue posizioni critiche di Venturi a sostegno degli”Otto” (con lo stesso Afro, Birolli, Corpora, Moreni, Morlotti, Santomaso, Turcato e Vedova), all’insegna di un superamento, preminentemente “politico” (di politica dell’arte, naturalmente), di realismo e astrattismo:..”
Ad Afro importa ben poco distillare una immagine misurata, calibrata, perfetta, aggiustare i toni, ricuperare accordi cromatici, che magari avevano deviato verso accentuazioni emotive e sottolineature psicologiche, se non gli è riuscito il miracolo di ricuperare un’immagine vera; se la pittura non è riuscita a rapportarsi alla verità:al sentimento delle cose, alla loro forza o alla loro leggerezza, alla labile precarietà di una memoria che riaffiorando riesce a riconoscersi, o all’impetuosa testimonianza di un ‘emozione sorpresa e raccolta nell’intenso, sorgivo momento della sua scoperta; non è determinante, per lui, che l’immagine si liberi completamente di ogni riferimento figurativo, o che talvolta se ne riappropri, quasi per fissare, per certificare un’appartenenza; ne che sia la modulazione del colore, o il magico, liberatorio e rigenerante trascorrere della luce attraverso i piani del dipinto, a rievocare il senso, il valore di un accadimento.
Sia che ci si debba affidare al filtro della memoria, attraverso la giustezza del tono e i confronti delle campiture, come avviene soprattutto negli anni cinquanta, sia che il mistero di un’emozione dipinta sia tutto riverso nello slancio del gesto e nel respiro palpitante di una massa cromatica, secondo i più tradizionali dettami dell’Informale, ancora imperante negli anni sessanta, sia che la realtà corrisponda a una forma completa e chiusa, in una sorta di tensione centripeta verso valenze etico-formali, finalmente riconosciute e definitivamente ricuperate, come ci conferma la straordinaria ultima stagione del Maestro, i conclusivi anni sessanta; determinante resta sempre la rispondenza dell’immagine non ad un oggetto rappresentato, ma alla valenza psicologica, sentimentale, emozionale, etica di quell’oggetto.
Afro aveva portato nel tessuto della pittura, negli strumenti del linguaggio, ma anche nel suo stesso fluire e dipanarsi, tutto il pulsare della vita.
Ed allora forse l’equivoco originario, perlomeno il taglio parziale e, come abbiamo già notato, limitante, di un quasi generale approccio critico nei confronti della sua opera, risiede in quell’aver troppo sottolineato le componenti di mestiere, di formidabile perizia ed abilità tecnica, di meticolosa e sapiente ricerca della perfezione formale. Certo Afro dipingeva come i classici, avendo come loro appreso il mestiere fin da giovanissimo, avendolo irrobustito e raffinato nella bottega, avendo continuato ad esercitarlo con rigorosissima disciplina fino a padroneggiarlo integralmente. Ma la padronanza degli strumenti altro non era che uno dei momenti della conoscenza, un passaggio imprescindibile per poter mettere la pittura al servizio della realtà. Afro dipingeva come i classici non per raggiungere, come invece tentavano loro, la bellezza, ma per riportare nella chiarezza, nella certezza della pittura la realtà dell’immagine; non rappresentata, ma vissuta.
La sua produzione, contrariamente a quello che si tende ad immaginare, è ricchissima di opere disarmoniche, antigraziose, apparentemente, solo apparentemente sconnesse sul piano formale, ed invece perfettamente, compiutamente riuscite. Pensiamo a dipinti come “ Il castello” del 1963, o “ Torre del Greco” dello stesso anno, in cui un’aria di tempesta agita e scompagina ogni cosa, rimettendo in discussione equilibri che sembravano definitivamente acquisiti. E per contro, se ci rivolgiamo a considerare tutto il percorso esecutivo di un’opera come “Il Giardino della Speranza”, all’Unesco di Parigi, certamente emblematica nella conferma di un tragitto avvenuto per gradi, per scoperte e stratificazioni, attraverso infiniti progetti e mille limature, altrettanti avvicinamenti, ripensamenti e ritorni, per poi giungere finalmente al riconoscimento conclusivo, a quel meraviglioso brano di pittura sulla speranza, ci accorgeremo che, anche in questo caso, la tecnica e i modi della classicità, l’immersione completa nel pozzo miracoloso del mestiere, erano funzionali ad un unico obiettivo: riconoscere e riportare nel magico, ma concreto, universo dell’arte, un’idea alta della vita.