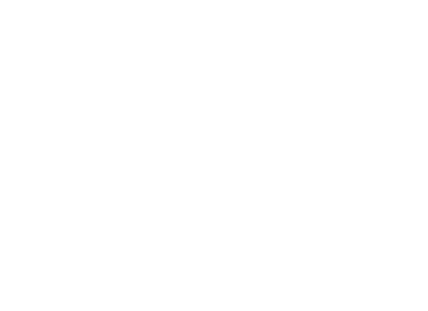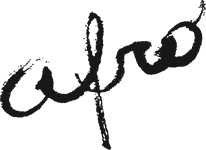“Dopo la grande prova de Il Gardino della Speranza Afro procede di furia, affretta i tempi e si espone alle raffiche del più veemente automatismo”. E ancora: “quale disperato rien ne va plus costrinse Afro a rinunciare ai suoi lenti pensieri?”. Nelle pagine più belle che sul pittore siano state scritte, dopo quelle più antiche di Brandi e così rispetto ad esse diverse, Gabriella Drudi riconosceva lucidamente la frattura che, al traguardo del 1958, la pittura di Afro patisce, o – meglio – sceglie: e s’interrogava sui motivi che a quello strappo poterono condurre1. Qualche ipotesi; poi, forse, una risposta, ancora di sé dubitosa: “o, semplicemente, divenuta la superficie della tela umiliata presenza, accettò il proprio affiorato presente nell’atto di dipingere?”. Poche parole, ma che danno luce sulla natura di quella svolta importante, per molti versi singolare. “Umiliata presenza” è, può soltanto essere per Afro la superficie: nozione che egli conquista ora a scapito di molto del suo più splendido passato: e che si darà, negli anni a venire, infinitamente lontana da quel luogo orgoglioso che essa era stata per gli americani. Appena, la superficie fu per lui, invece, terra d’un aspro raccolto: ove specchiare quell’“affiorato presente” cui sentiva di voler dare immagine: stanco, adesso, delle seduzioni, degli incanti infiniti della memoria.
Fino a tal punto rifondarsi, per un pittore che stringeva da un lustro almeno un’altissima maturità (riconosciuta – ed è caso raro per un italiano – prima negli Stati Uniti, ove musei e prestigiose collezioni l’avevano per tempo seguito con interesse; ma infine sancita anche in patria, con il premio importante alla Biennale di Venezia del ‘56), voleva dire muovere un passo rischioso: prima di tutto nei confronti di quel mercato statunitense che aveva positivamente accolto di lui la resistente natura in tutto europea del linguaggio, e che avrebbe certo guardato con maggior sospetto un suo ripiegamento su accenti che richiamassero modi di un’ormai peraltro inattuale pittura d’azione. Se corse quel rischio, nulla ci autorizza a presumere ch’egli non l’abbia fatto con piena consapevolezza: rispondendo a una pulsione dell’animo in lui fonda, e ormai irrinunciabile.
Afro non ha scritto spesso, né volentieri, sulla sua poetica: ma un testo, probabilmente risalente alla fine del ’57, è – a rileggerlo oggi – prezioso a intendere la ragione del nuovo orientamento che egli s’apprestava a dare alla sua pittura. “Da tempo provavo un certo disagio di fronte al mio lavoro: ero estraneo al quadro che realizzavo come se non rispondesse a uno svolgimento, ad una necessità interiore che diveniva più urgente e precisa. La mia pittura è sempre stata soggettiva, ho sempre cercato uno spazio fatto di memoria e ritrovato per sentimento e intuizione; ma certi simboli rappresentativi che mi erano sembrati dar ordine, in un certo senso stabilire il nesso con la realtà, sono divenuti recentemente privi di interessi, schermi fra me e il quadro, ostacoli a nuove scoperte. Certi elementi figurativi, anche filtrati al massimo o ridotti ad abbreviazioni ideografiche, di cui prima avevo sempre creduto di aver bisogno, ora mi apparivano detriti malinconici, familiari come cifre, ma non veri. Sentivo il mio lavoro lontano da me perché non mi bastava rappresentare una realtà di fantasia, di sogno o di memoria […], ma volevo che quella realtà si identificasse con la pittura e la pittura divenisse la realtà stessa del sentimento, non la sua rappresentazione […]. Della memoria resta l’indistinzione, un’onda lenta che trascina con sé tutto il sapore di una stagione, ma non più le sue conformazioni, nemmeno più l’ombra dell’ombra ma solo l’infinito ‘negativo’ di quelle forme ricordate, piuttosto che il limitato sebbene indefinito ‘positivo’”. Così Afro scriveva a Lionello Venturi, che gli aveva sollecitato una testimonianza per il suo Pittori italiani d’oggi, che uscirà da De Luca nel ’58; ed è facile scoprire in questa pagina, già interamente espresso, un radicale ribaltamento di quelle che erano state, almeno a partire da ’52, le sue più antiche ragioni di forma.
Proprio allora (probabilmente all’inizio del ’53), un’altra fra le rare “confessioni sulla mia pittura” Afro l’aveva affidata ad Umbro Apollonio, dicendo fra l’altro come le sue immagini fossero “ancora un corrispondente poetico della realtà, di cui la memoria conserva la parte più essenziale, rifiutando tutto che sia pratica ed esperienza. Una realtà decantata, direi […]. La pittura così intesa nel suo rapporto con la vita, da cui continuamente si alimenta e si rinnova, ti investe in modo totale, per cui tu ci sei dentro con tutte le tue reazioni, lati del carattere, ossessioni, uno spiraglio aperto sulla tua anima”. Alla fine del ’54, poi, quando la sua più riconosciuta stagione è lì per giungere al suo culmine, in una lettera a Andrew Ritchie (che l’avrebbe pubblicata nel ’55 nel catalogo della mostra The New Decade al Moma di New York, e la cui minuta è conservata nell’Archivio Afro, a Roma – come d’altronde gli altri documenti qui citati), scrive: “L’organismo rigorosamente formale di una pittura può contenere la leggerezza, il respiro di un’evocazione, l’improvviso soprassalto della memoria?”. Si rispondeva di sì; e poco più oltre: “sento che la sostanza del mio colore, lo sviluppo della mie linee creano uno spazio che non è altro che lo spessore della memoria [..]; sento che il mistero con cui la mia intera vita sfocia nella pittura può essere inteso all’inverso e permettere alle immagini della pittura di risalire fino alle origini della mia vita. Così non ho paura della parola ‘sogno’, non ho paura della parola ‘lirica’, o della parola ‘emozione’”; quand’anche egli sappia bene che quelle parole sono “oggi assai poco favorite [dalla] più attuale pittura contemporanea”.
La semplice collazione di questi tre brevi scritti di Afro, scalati dunque rispettivamente al ’53, ’54 e ’57, consente di valutare pienamente la radicale riforma che il pittore va imponendo al proprio ‘soggetto’. Costituito, dapprima, da un ‘vero di memoria’ che prende avvio da un’emozione provata di fronte all’esistente, poi se ne fa lontano, per infine tornarvi: in una sorta di respiro ansimante che perfettamente corrisponde a quel flettersi lento del colore sulla pagina pittorica dal primo piano al fondo, in un lungo viaggio tramato di antiche, quasi alchemiche sapienze. Un colore che in questo tempo – giusto a cavallo della metà del sesto decennio, dunque – s’è fatto, sino in fondo, interno e segreto, quasi annidato nel manto della pittura. Per velature infinite, per sottilissime inframissioni di esili corpi cromatici, la figura sale dal fondo, affiora un attimo alla superficie, frana di nuovo. Brace ancora viva sotto la cenere, i rossi bruciati e gli aranci squillanti, come altrove i celesti d’acqua e gli azzurri profondi, fanno assieme un brusio mai stanco sotto la coltre dei grigi: così che dura a lungo, suadente, l’immagine di Afro.
Sia ad Apollonio che a Ritchie, Afro parla di quello che è per lui la “memoria”: non un malinconico riandare del sentimento ad un’esperienza trascorsa, non un rimpianto o la percezione di un’assenza, ma al contrario l’istante, e il modo, in cui la realtà – a noi esterna o in noi interna, identicamente – conquista la sua interezza di senso, e in cui la conoscenza, scalzando la casualità dell’esperienza, si fa fonte di verità. Piuttosto che riattualizzare il passato, Afro – attraverso la memoria – lo depura così dei suoi sensi più caduchi (ed è proprio questo che ne stabilisce la grande distanza rispetto a quanto vanno facendo gli stessi anni altri suoi compagni di strada del “gruppo degli Otto”, quali ad esempio Birolli o Corpora): e ‘giustifica’ a se stesso, e alla limpida intenzione astratta della sua pittura, il bisogno oscuro che sente di non rescindere del tutto il rapporto con il mondo.
Tutto ciò, Afro l’ha prima intuito concettualmente o, piuttosto, l’ha riconosciuto a posteriori nella sua pittura? Interamente pittore com’era (anche al di là di talune letture critiche che lo videro riduttivamente costretto entro quell’unica sua dimensione) possiamo propendere per la seconda ipotesi.
Diversamente occorre dire a proposito della sua ‘svolta’ della fine degli anni Cinquanta: quando l’egida del pensiero sembra precedere gli slanci della mano. Nel momento in cui apertamente confessa a Venturi “un disagio di fronte al lavoro” e un progetto di sua rifondazione, egli non fa altro che attestare la piena consapevolezza per dir così teorica del passo che sta per compiere, ma che – a quella data – non ha ancora perfettamente elaborato nel concreto della pittura. Certamente non gli è facile, allora, sospendere quel suo modo – di lenta, precisissima e insieme abbandonatamente emozionata e lirica spazialità, respirante al cuore del suo dipinto – che l’aveva portato a capolavori quali, fra quelli oggi in mostra, Figura I, Figura II, Stagione nell’ovest, Tempo coperto, per dire solo di alcuni; un modo che ormai era riconosciuto come suo, e prezioso, di là e di qua dell’Oceano.
Diverso il caso del grande ‘studio’ (quasi tre metri di lunghezza) relativo a quell’opera e che ne porta il medesimo titolo: opera oggi qui esposta a fianco di molti disegni, inchiostri e tecniche miste preparatori, che può ben dirsi perfettamente autonoma dal murale per l’Unesco. Nell’elaborazione di quest’immagine, Afro si sente certamente più libero, e più disposto a rischiare sulla via che, come ha appena confidato a Venturi, vuole adesso per sé. Egli rinunzia infatti a qualcosa che gli era intimamente connaturato: a quel serrare, in particolare, attorno a un gorgo centrale le forme sfibrate della sua ‘figura’.
La grande dimensione di questo ‘studio’ (il cui tempo di esecuzione è in realtà subito successivo a quello del murale) spinge dunque Afro a immaginare uno spazio meno contratto attorno al nucleo centrale dell’immagine, e occupato come da una historia che si distenda, col ritmo suadente del racconto, per tutta la lunghezza della tela. Senza, però, che la spazialità – nemmeno nello ‘studio’ – arrivi ad essere concepita come un indifferenziato all over: insistendovi comunque le forme nel disporsi sul filo ideale dell’orizzonte, che dà gerarchia ed ordine allo spazio, ed in particolare aggregandosi i due gran colpi del nero, dati a breve distanza l’uno dall’altro, nel fuoco ideale della composizione. Spazio, peraltro, che è ancora inteso e realizzato come profondità entro la quale le forme giocano il ruolo consueto di lenti affioramenti e fonde retrocessioni, legate tutte da una ‘antica’ sorvegliatezza nell’uso del tono come collante ultimo della spazialità antiprospettica del dipinto. Una fedeltà, questa serbata sempre da Afro al valore tonale del colore, che, più che riconnetterne l’opera a sovrastoriche e troppo generiche radici veneziane (come se infine Venezia non avesse contato il colore di Lotto accanto a quello di Giorgione), la stringe alla lunga tradizione del tonalismo romano, radicata fin dagli anni Trenta del secolo a Roma, ove Afro compie allora la sua prima educazione, e ininterrotta nel dopoguerra, nel Turcato delle Rovine di Varsavia, ad esempio, e persino nei primi grandi sacchi di Burri.
Questo ed altro è stato Il Giardino della Speranza: la cui complessa elaborazione si legge in filigrana nei tanti piccoli pensieri su carta (riuniti oggi attorno al grande ‘studio’) che Afro andava appuntando nello “studio meraviglioso” del Mills College, i primi mesi del ’58, ove la “parete” dell’Unesco è divenuta “la sola preoccupazione” di un’esistenza scandita dai giorni solitari e laboriosi trascorsi fra quello studio e la “casetta nel parco” che gli è stata assegnata, ove “come a Procida, mi faccio da mangiare da solo”. “Una Procida senza amici”, gli sembra allora il grande spazio californiano; intorno, solo “alberi stupendi” e “tante belle giovani ragazze. Fa piacere vederle: sono come dei fiori, degli uccelli”. Nei piccoli fogli che preparano il murale, Afro dissemina sapienze antiche accanto a nuove ipotesi di forma: qui la penna s’impunta e cerca, tornando su se stessa, ancora ‘figure’ gorkiane (anche se, in una lettera a Scialoja del novembre 1957, aveva scritto dei dubbi che, stavolta, gli ha sollevato la pittura di Gorky); là l’inchiostro si fa più liquido, cercando atmosfere. Altrove la ‘figura’ si apre, allungandosi sulla pagina in macchie e crampi di colore: e sono probabilmente questi i fogli nei quali Barbara Drudi ha ravvisato quella “rinnovata libertà gestuale” che poi, nel murale e in parte nello stesso grande ‘studio’, sarà posta in sordina.
Ma datano a questo stesso 1958, senza che sia possibile stabilirne meglio la cronologia rispetto alla tela per l’Unesco, dipinti che attestano come la ‘svolta’ di Afro sia in atto, ormai, non solo nelle intenzioni confessate a Venturi, ma anche nella pittura. Fra questi,Valle del ferro – esposto nella mostra odierna – è forse il primo che, messi drasticamente al bando quei “simboli […] familiari come cifre, ma non veri” che erano stati per tanti anni il suo ultimo rampino gettato sulla sponda lontana della realtà di natura, scandisca sulla tela i colpi netti di un colore nettamente asserito, deposti sulla superficie dall’ansia e dall’affanno. Davvero, allora, inValle del ferro, può dirsi che, come ormai vuole, della memoria resti solo “l’indistinzione”. Ora che sente l’urgenza di una “materia [che] nasca dai suoi stessi strati di calcolo e di abbandono”: che è frase, nel ricco argomentare che Afro fa nella lettera a Venturi, nella quale è facile ravvisare la suggestione dei discorsi da tanto tempo, e quotidianamente, scambiati con Toti Scialoja.
Scialoja, che è per certo vicino come nessun altro ad Afro in questo momento in cui egli scambia una maturità interamente posseduta con i nuovi progetti. Valle del ferro, peraltro, segna anche il limite, mai superato in questi anni Cinquanta che digradano, in cui Afro intese trattenere la sua adesione ad una pittura di gesto. La tela è percorsa, e quasi percossa, dal ritmo alterno dei bianchi e dei neri: e da questo sincopato e franto andamento scritturale essa è ad evidenza tramata; ma non meno contano quei grigi in gamma infinita che accolgono e danno asilo alla dialettica aspra del bianco nero. “Il bianco e nero è il colore della superficie piatta […] o, all’inverso, quando converge nel grigio, il colore dell’atmosfera”, ha scritto – a proposito di de Kooning – Gabriella Drudi: e il grigio è appunto quanto assicura ad Afro e alla sua nuova foga quell’alveo spaziale capiente che stringe il passato al presente: la memoria alla presenza. Cesare Brandi l’aveva d’altronde già visto, questo modo in cui persino i neri erano dalla “luce in trasparenza” – la luce eterna di Afro – “sospesi come a mezz’aria”: disinteressati a scrivere, soltanto, la superficie dell’opera.
Bianchi che si affogano di ombre, di nebbie, di veli; e s’ingolfano in pigre oscurità, in caligini notturne. Neri che crepitano luce, e si sotterrano nel chiarore che tutto intorno li assedia. Così sarà – in questa sua prima stagione, che scorre dal ’58 almeno fino a tutto il ’60 – il bianco e nero di Afro. Colore fra altri colori, il nero: perché il verde di Trifoglio (1958), ad esempio, o il rosso clamante del Senza titolo dello stesso ’58 (Buenos Aires, collezione privata), o diVia della Croce (1959), dicono lo stesso: la ricerca d’un timbro che squilli fra gli altri – o “di un colore che s’accenda ‘fuori misura’”, secondo quanto aveva detto lui stesso.
Raramente s’avverte, adesso, l’intera rinunzia alla definizione dei trapassi tonali che assicurano alla tela la sua acquorea e lentamente digradante profondità. Se davvero appartiene al ’58, il Nero piccolo (Catalogo generale, n. 406) è – appunto in una dimensione quasi di bozzetto – il primissimo avviso della temperatura diversa cui salirà la pittura solo a muovere dal ’61, e sulla quale si registreranno molte opere datate fra ’62 e ’63. In esso, le forme nere – ovoidali, imperfettamente circolari, come l’una all’altra annodate in una danza misteriosa – designano ormai non altro che la superficie, scrivendosi su quel bianco calcinato che non è più fondo capiente, ma parete che respinge verso il primo piano. Sulla stessa linea si disporrà Passaggio obbligato del ’59; poi, più gestualmente sommosso, il Tempo coperto del ’60. Infine, al culmine di questa stagione, i due capolavori de Le fosse (Sutri), del ’62, e de Il castello della Galleria Nazionale di Roma (1963).
In ognuna di queste tele, affiancate da altre minori e da un lavoro su carta intenso e sovente felicemente sperimentale, Afro attinge una dimensione nuova, che bruscamente ne allontana l’immagine di sapiente “pittore di grazia” così incongruamente, allora, talvolta attribuitagli. Certo, poté pesare in qualche misura l’incontro romano – quei giorni stessi – con Willem de Kooning (che, al contrario di quanto spesso si asserisce, egli conobbe solo allora), e la visione diretta dei Roman paintings , dei Black and white. Rome, dipinti proprio nello studio di cui Afro gli aveva offerto l’uso, tra fine ’59 e primi mesi del ‘60. Né va considerata, questa sponda del lavoro di Afro, come esclusivo approdo della sua pittura di quel tempo: ché anzi essa si diede in presenza di altro lavoro, diversamente orientato verso quella persistenza dell’antico canone formale che sarebbe d’altronde tornato a farsi egemone sulla metà del decennio. Ma occorre ricordare che la ‘svolta’ di Afro ebbe origine ben prima dell’incontro con de Kooning, ed è annidata già nelle sue parole, preveggenti, del 1957.
1. In questo testo s’è fatto riferimento alle seguenti voci della bibliografia su Afro: L. Venturi, Pittori italiani d’oggi, Roma, De Luca Editore, 1958; G. C. Argan, Il giardino della speranza. Una parete di Afro, “Quadrum”, Bruxelles, n. 6, 1959; G. Drudi, Willem de Kooning, Milano, Fratelli Fabbri Editori, 1972; C. Brandi, Afro, Roma, Editalia, 1977; G. Drudi, Immagini di Afro, Roma, Edizioni della Cometa, 1986; F. D’Amico, Afro. Corrispondenza e altri scritti 1949-1960, in Afro. L’itinerario astratto. Opere 1948-1975, cat. della mostra a cura di L. Caramel, Milano, Mazzotta, 1989; B. Drudi, Afro per l’Unesco: il murale e gli studi preparatori, in La soluzione lirica. Afro, cat. della mostra a cura di P. L. Siena e M. Vescovo, Wien-Bozen, Folio Verlag, 1995; Afro. Catalogo Generale Ragionato, Roma, Dataars, 1997.